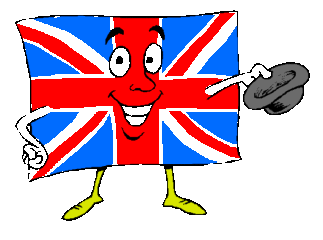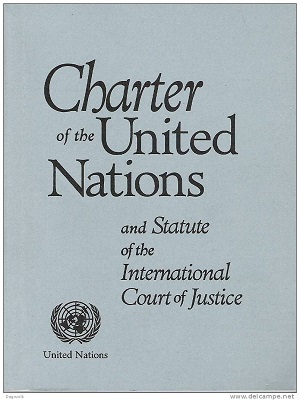L’Italia e la gestione dei migranti: il caso Khlaifia c. Italia
Le nuove politiche avviate dal governo Movimento 5 Stelle – Lega in tema di controllo dei flussi di migranti nel Mediterraneo hanno causato una spaccatura nell’elettorato italiano, in parte molto critico nei confronti di una “linea dura” considerata rischiosa per la tutela dei diritti fondamentali dei migranti. Inevitabilmente, per l’Italia, la questione della gestione dei flussi e dei controlli dei migranti arrivati sulle nostre coste resta incredibilmente attuale.
Non è infatti prima volta che le autorità italiane si trovano a dover rispondere delle proprie scelte in materia di gestione dei flussi e di controllo dei migranti arrivati sul territorio del nostro paese.
Il caso Khlaifia e altri c. Italia[1]
Nel caso di specie, i ricorrenti, tre tunisini, vennero salvati da un naufragio e condotti al CSPA (Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza) di Lampedusa, un centro caratterizzato da pessime condizioni igienico-sanitarie e da un cronico sovraffollamento, e lì vi rimasero per qualche giorno, fino allo scoppio di una violenta rivolta, seguita da una manifestazione da parte dei migranti che occupavano la struttura. Molti di questi, fermati dalla polizia, furono poi spostati a Palermo e, da qui, alloggiati temporaneamente su alcune navi attraccate nel porto; i ricorrenti, riguardo a questa sistemazione temporanea, parlarono di una situazione difficile: anche le navi, così come il CPSA, erano infatti sovraffollate, senza i servizi necessari ad accogliere centinaia di persone e gli ospiti, secondo quanto affermato dai ricorrenti, furono oggetto di prevaricazioni e tenuti sotto stretta sorveglianza delle autorità, senza possibilità di ottenere informazioni sul proprio status[2]. Dopo una settimana, i tre ricorrenti vennero portati all’aeroporto di Palermo, qui raggiunti da un provvedimento di espulsione – redatto in un modulo standardizzato, uguale per ciascuno di loro – e fecero ritorno in Tunisia. Su questo punto, va evidenziato come la velocità della procedura si deve all’accordo bilaterale tra Italia e il paese nord-africano, in forza del quale è ammissibile il rimpatrio dei cittadini tunisini arrivati in Italia illegalmente dopo un semplice riconoscimento[3].
In seguito, diverse associazioni fecero ricorso a nome dei migranti, lamentando le pessime condizioni igienico-sanitarie dei centri di accoglienza, il sovraffollamento delle strutture e la mancanza di adeguata assistenza, nonché la condotta oppressiva delle autorità sorveglianti. Il GIP, tuttavia, decise di archiviare il fascicolo, affermando come le condizioni delle strutture di accoglienza non fossero così critiche da integrare un reale rischio per la salute dei migranti. I giudici rilevarono inoltre come la soluzione adottata dalle autorità, sia per quanto concerne il breve soggiorno sulla nave nonché la rapidità con cui è avvenuto il respingimento, fosse legata al particolare stato di necessità dovuto ai tumulti occorsi a Lampedusa. Inoltre, come evidenziato dalle corti interne, nessuno dei ricorrenti inoltrò richiesta d’asilo, mentre coloro che proposero domanda furono immediatamente spostati in altri centri. In altre parole, ai migranti furono riconosciuti tutti i servizi necessari per tutelare la loro salute, il loro benessere e i loro diritti e qualsiasi atto dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizie era giustificato da un generale stato di necessità – causato non solo dai tumulti avvenuti a Lampedusa ma anche dalle difficoltà connesse alla gestione di un improvviso aumento degli arrivi[4].
La normativa di riferimento a livello internazionale, comunitario e interno
A livello internazionale, sono diversi i documenti da prendere in considerazione per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Un primo esempio è la Risoluzione del dicembre 2014 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite[5], in cui si riconosce il diritto di ciascun paese di espellere stranieri dal proprio territorio, seppur nel rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale (art. 3), dei diritti umani (art. 13) e di un generale principio di legalità (art. 5), punendo le espulsioni collettive (art. 9); su quest’ultimo punto, va evidenziato come questo divieto sia motivato dal fatto che, in caso di espulsione, è necessario che ogni domanda vada analizzata alla luce delle circostanze individuali di ciascun richiedente. Inoltre, anche nel diritto internazionale, è vietato il ricorso alla detenzione o a forme simili di privazione della libertà se non per periodi limitati di tempo e per esigenze connesse all’espulsione (art. 19).
Particolarmente rilevante è anche la Direttiva 2008/115/EC del 16 dicembre 2008 (la c.d. Direttiva rimpatri) “recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Ai sensi della Direttiva, gli Stati sono liberi di garantire dei periodi di “rimpatrio volontario“, permettendo ai migranti di tornare in patria senza particolari formalità, al termine del quale è possibile procedere ad espulsioni[6], anche coatte, come ultima misura di fronte ad individui reticenti – pur nel rispetto di un generale principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 8) dei provvedimenti adottati dalle autorità. Particolarmente importante, in quest’ambito, è la previsione di cui agli artt. 12 e 13, che, rispettivamente, tutelano il diritto dei migranti ad essere informati sul proprio status e il diritto a ricevere assistenza legale. In tema di detenzione, la Direttiva, all’art. 15, conferma come la detenzione sia un provvedimento da usare solo come “last resort” e solamente in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento, rispettando non solo i requisiti formali previsti dal §2 – tra cui anche la necessità di un provvedimento dell’autorità scritto e motivato, ma anche quanto prescritto dall’art. 16 sulle condizioni dei detenuti e delle strutture utilizzate per il loro collocamento. Inoltre, l’art. 18 dispone che “nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (…) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento”.
Ma possiamo parlare di una “situazione anomala” rispetto al caso Khlaifia?
Come evidenziato da un report del Consiglio d’Europa[7] e di Amnesty International[8], l’eccezionale ondata di arrivi, motivata dallo scoppio delle “primavere arabe”, risultò essere difficilmente gestibile a livello logistico, soprattutto in un’isola piccola come Lampedusa, avendo messo a dura prova le capacità delle autorità italiane e avendo richiesto lo sforzo congiunto di diverse organizzazioni internazionale; l’aumento degli arrivi causò una inevitabile contrazione nelle possibilità di accesso ad alcuni servizi essenziali, avendo ridotto le possibilità di veder tutelati diritti fondamentali come quello all’informazione sul proprio status o alle cure mediche. Un aspetto che emerge poi con chiarezza dal report di Amnesty riguarda le modalità con cui furono – e sono tuttora – realizzate le espulsioni di molti migranti di origine tunisina: nell’opinione dell’organizzazione, l’accordo tra Italia e Tunisia, velocizzando le procedure di rimpatrio, finiva con il ledere i diritti individuali, tali da rendere queste espulsioni, nei fatti, sommarie e, pertanto, contrarie al diritto internazionale e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
La normativa italiana non sembra tenere conto di questi profili e si espone, al contrario, a evidenti critiche: la c.d. legge Bossi-Fini (d.lgs. 286/98) è infatti parecchio chiara nel riconoscere come il questore possa disporre l’allontanamento di tutti gli individui entrati illegalmente sul territorio (articolo 10), i quali possono essere trattenuti “presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino” (articolo 13). La legge, benché molto netta, si scontra però con una realtà pratica che molto spesso non permette di eseguire in maniera celere espulsioni e rimpatri, causando un sovraffollamento delle strutture pensate per ospitare temporaneamente persone in attesa di espulsione[9].
La risposta della Corte EDU
La Corte si è pronunciata sul caso sia in seconda sezione, sia, successivamente, in Grande Camera, con alcune importanti differenze sulle conclusioni raggiunte nelle due diverse sedi.
I ricorrenti lamentarono violazioni di una serie di articoli della Convenzione connessi a quanto accaduto nel corso della loro permanenza in Italia, sia per quanto riguarda la loro permanenza nel centro di accoglienza (violazione dell’art. 5 CEDU per illegittima privazione della libertà personale), sia le condizioni delle strutture (violazione dell’art. 3 CEDU per le pessime condizioni del CPSA nonché delle navi in cui vennero temporaneamente alloggiati nel porto di Palermo), sia per essere stati vittime di una espulsione collettiva (vietata dall’art. 4 prot. 4 CEDU). Inoltre, i ricorrenti lamentarono l’impossibilità di accedere a rimedi effettivi per far valere le proprie doglianze di fronte ad un giudice interno (con conseguente violazione dell’art. 13 CEDU).
Per quanto riguarda le doglianze di cui all’art. 5, le Grande Camera ha sostanzialmente confermato quanto già affermato dalla seconda sezione[10]. In entrambi i casi, la Corte rileva infatti come, indipendentemente dal rispetto formale delle norme su accoglienza e collocamento, i presupposti del provvedimento di detenzione devono essere valutati in relazione al caso di specie. La violazione della norma sussiste in particolare per il fatto che i migranti vennero ospitati nel CSPA contro la loro volontà e senza possibilità di contestare o fare ricorso contro la misura che ne imponeva il trattenimento. Inoltre, essendo stati trattenuti in un CSPA e non in un CIE, come previsto dalla normativa italiana in questi casi (art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione),il trattenimento risultava privo di base legale [11]. Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano adempiuto a quegli obblighi di informazione previsti dall’art. 5 §2 CEDU, ai sensi del quale le autorità devono condividere con gli interessati i “dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico”. Su questo punto, i giudici di Strasburgo hanno rilevato come le informazioni fornite ai migranti – che erano a conoscenza del loro status e dei motivi per cui erano stati accolti nel paese – non fossero in ogni caso sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dal dettato convenzionale[12]. La Corte ha inoltre riconosciuto come vi sia stata violazione dell’art. 5 §4, il quale dispone che “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale”. Su questo punto, il “combinato disposto” di queste due mancanze resero pressoché impossibile, per i ricorrenti, l’opposizione a quanto disposto dalle autorità, con conseguente violazione della norma in oggetto[13].
In aggiunta, i ricorrenti lamentarono la violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU: tale doglianza si fondò, in particolare, sulle condizioni critiche delle strutture e dei luoghi in cui sono stati collocati, tra sovraffollamento, pessime condizioni igienico-sanitarie e mancanza di servizi essenziali. Anche in merito a questa doglianza, il Governo eccepì come i provvedimenti adottati fossero dovuti alle particolari ed eccezionali circostanze dovute all’aumento dei flussi da Libia e Tunisia, senza però invocare quella deroga prevista per gli stati di emergenza di cui all’art. 15 CEDU. Nella prima pronuncia della Camera, la Corte rilevò come “questi fattori non possono tuttavia esonerare lo Stato convenuto dal suo obbligo di garantire che ogni persona che, come i ricorrenti, viene ad essere privata della sua libertà possa godere di condizioni compatibili con il rispetto della sua dignità umana”[14].
Nel decidere sulla sussistenza una violazione del divieto di cui all’art. 3, la Corte, in seconda sezione, ha valutato separatamente il periodo di detenzione nel CSPA e il periodo in cui i ricorrenti vennero trattenuti sulle navi nel porto di Palermo: rispetto al soggiorno nel CSPA, i giudici hanno riconosciuto la violazione dell’art. 3 per le già viste mancanze del centro di accoglienza e le pessime condizioni della struttura, aggravate anche dalla situazione di particolare vulnerabilità dei ricorrenti, salvati da un pericoloso viaggio in mare[15]. Al contrario, per quanto riguarda il periodo di soggiorno sulla nave, la Corte di Strasburgo non ha rilevato violazione della norma in oggetto non per delle specifiche valutazioni sulle reali circostanze relative alla condizioni dei migranti, quanto più per la mancanza di riscontri fattuali che diano fondamento alle doglianze dei ricorrenti; in questa situazione, la Corte non può far altro che concordare con la conclusione del governo[16].
Invece, la Grande Camera, nella sua pronuncia, non solo valuta con maggior sensibilità la situazione di emergenza materializzatasi nel caso di specie, ma ribadisce anche alcuni aspetti centrali della propria giurisprudenza, che rappresentano un utile metro valutativo per casi simili. Una violazione dell’art. 3 CEDU può sussistere, in primo luogo, qualora i ricorrenti denuncino trattamenti o condizioni di vita che arrivino ad un “minimo livello di gravità”, specificando come questa valutazione “dipende dal complesso degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psicologici nonché, talvolta, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima”[17]; su questo punto, emerge come sia centrale, per la Corte, tutelare soggetti in particolari condizioni di vulnerabilità, come, appunto, i migranti. Su questo punto, i giudici riprendono quella radicata giurisprudenza che, in tema di tutela degli individui in carcere e simili strutture detentive, stabilisce come ad ogni individuo debba essere concesso sufficiente spazio vitale, accettabili condizioni igienico-sanitarie e l’accesso a servizi essenziali per il suo benessere psico-fisico[18]. Inoltre, come emerge anche dalle conclusioni del caso di specie, è necessario che i ricorrenti presentino sufficienti prove a sostegno delle loro doglianze.
Analizzando le prove a disposizione, la Corte rileva come la violazione dell’art. 3 CEDU non sussista né per quanto riguarda il periodo di collocamento nel CPSA né, confermando la precedente sentenza, per il tempo trascorso sulla nave. In particolare, i giudici eccepiscono come, rispetto alla precedente valutazione, i migranti nel CPSA vivessero in una situazione tutto sommato accettabile, avendo a disposizione margini di libertà di spostamento, l’accesso a servizi essenziali – garantiti anche dalle associazioni attive in loco. Inoltre, in ogni caso, i trattamenti denunciati hanno comunque avuto una durata breve. Rispetto al periodo sulla nave, invece, i giudici della Grande Camera si conformano alle valutazioni dei colleghi, ravvisando come non vi fossero sufficienti prove tali da confermare la versione dei ricorrenti, rigettando in blocco le loro doglianze sotto l’art. 3 CEDU[19].
Particolarmente centrale è anche la questione relativa alla supposta violazione dell’art. 4 del Protocollo 4 alla CEDU, il quale pone il divieto, per le autorità nazionali, di compiere espulsioni collettive, ovvero di espellere un individuo senza considerare le circostanze del caso di specie, nonché le situazioni e le esigenze personali di ogni soggetto. I ricorrenti accusarono le autorità italiane di aver realizzato una serie di espulsioni contrarie ai principi fondamentali della Corte in tema di espulsioni collettive, facendo ricorso a provvedimenti standardizzati, ignorando le situazioni personali di ciascun individuo e solo sulla base della nazionalità dei migranti.
In seconda sezione, la Corte ha concordato con i ricorrenti e ha ravvisato violazione della norma, affermando in particolare come “… la semplice messa in atto di una procedura di identificazione non è sufficiente per escludere l’esistenza di una espulsione collettiva” e che “… i decreti di respingimento non contengono alcun riferimento alla situazione personale degli interessati…”[20].
Nella sua valutazione, la Grande Camera, però, riprende la ratio sottesa a questo divieto, evidenziando come le autorità abbiano l’obbligo di valutare ogni singola situazione individuale prima di procedere a rimpatrio di uno straniero – o a provvedimento simile, dacché la norma ricomprende qualsiasi forma di allontanamento dal paese, anche in via differita. I giudici si domandano dunque se i ricorrenti abbiano avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni e se, per converso, le autorità italiane abbiano messo in atto tutti i provvedimenti utili allo scopo. Rispetto al caso di specie, la Corte ricorda come i ricorrenti abbiano avuto a disposizione colloqui individuali con mediatori culturali e interpreti, nonché con altri rappresentanti di organizzazioni esterne ai centri di accoglienza, potendo mettere per iscritto le proprie ragioni – indipendentemente dal fatto che poi tali moduli siano andati distrutti durante i tumulti occorsi nel CPSA[21]. In altre parole, la Corte ritiene che, rispetto alla posizione dei tre ricorrenti, le autorità italiane abbiano tutelato il diritto di essere ascoltati e hanno dunque valutato le posizioni individuali di ciascun ricorrente. A conferma della bontà della condotta delle autorità italiane, i giudici evidenziano come alcuni migranti, dopo essere stati ascoltati, hanno avuto effettivamente accesso alle procedure per introdurre domanda d’asilo. Anche su questo punto, dunque, la Grande Camera ha riformato la pronuncia del precedente collegio, riconoscendo come non vi sia stata violazione dell’art. 4 del protocollo 4 CEDU[22].
I ricorrenti, infine, eccepirono una violazione dell’art. 13 CEDU in quanto non fu possibile accedere a nessun rimedio effettivo per sollevare le predette violazioni di fronte ai giudici nazionali. Su questo punto, occorre evidenziare come, per opporsi ai decreti di respingimento, nonché per contestare le pessime condizioni delle strutture in cui i migranti furono alloggiati, l’unico rimedio fosse il ricorso al Giudice di pace, il quale, però, non ne può sospendere l’applicazione: in questo senso, detto rimedio non può essere considerato effettivo, in quanto non avrebbe potuto sanare le violazioni dei diritti fondamentali in corso, con conseguente violazione del diritto ad un rimedio effettivo[23].
Conclusioni
In primo luogo, non si può certamente ignorare il drastico cambiamento di prospettiva adottato dalla Corte nelle due sentenze, in particolare per quanto concerne il concreto trattamento subito dai migranti sia per quanto riguarda la prima accoglienza sia per le procedure di rimpatrio messe in atto dalle autorità italiane. L’approccio della Corte evidenzia come la questione sia complessa e, per questo, ancora aperta a dibattito.
Dal punto di vista giuridico, infatti, come evidenziato dai giudici Sajó e Vuċiniċ nella loro opinione sulla sentenza della seconda sezione, il profilo relativo all’esecuzione di procedure di espulsione merita certamente maggiore attenzione: si può infatti parlare di “espulsioni collettive” sono nei casi in cui le autorità espellano un soggetto per la semplice appartenenza ad un gruppo o, per converso, quando un intero gruppo venga fatto oggetto di espulsione sulla base di una caratteristica comune, senza che si proceda ad identificazione.
Prendendo invece in considerazione la realtà che le autorità italiane affrontano, la Corte si trova a doversi pronunciare sul difficile equilibrio tra le esigenze degli Stati impegnati nella gestione dei flussi dei migranti e la tutela dei diritti umani dei migranti. Rispetto al nostro paese, gli accordi di rimpatrio tra Italia e paesi africani possono essere certamente uno strumento utile per gestire aumenti improvvisi di arrivi sulle coste italiane, ma rappresentano certamente un “rischio” per i soggetti esposti. Anche l’esistenza stessa di centri di rimpatrio ed espulsione, pur non essendo vietati dalla giurisprudenza della Corte, dovrebbero essere gestiti in maniera coerente alle esigenze di tutela dei singoli ospiti: in questo senso, i giudici di Strasburgo sembrano essere molto tolleranti nei confronti delle autorità nazionali, ammettendo anche soluzioni di emergenza – come, nel caso di specie, il ricovero su una nave – pur nel rispetto dei diritti fondamentali. Resta però centrale – ed emerge spesso nelle valutazioni della Corte – il ruolo di organizzazioni esterne al circuito di accoglienza nazionale, decisive per compensare le mancanze delle autorità nel garantire i diritti fondamentali degli individui.
___
[1] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, ricorso n. 16483/12, sentenza 1° settembre 2015 (seconda sezione) e 15 dicembre 2016 (Grande Camera).
[2] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 15 dicembre 2016, §§11 – 14.
[3] Ibid., §16.
[4] Ibid., §§22 – 29 e §§36 – 40.
[5] Risoluzione A/RES/69/119, 10 dicembre 2014.
[6] In caso di espulsioni per via area, la Direttiva stabilisce come queste espulsioni debbano essere compiute ai sensi della decisione 2004/573/EC.
[7] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., §§48 – 49.
[8] Ibid., §50
[9] Come evidenziato nel rapporto della Commissione diritti umani del Senato, Ibid., §35.
[10] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., §§56 – 57.
[11] Ibid., §§65 – 73 e §§93 – 107.
[12] Ibid., §§115 – 121.
[13] Ibid., §§128 – 135.
[14] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 1° settembre 2015, §128.
[15] Ibid., §135.
[16] Ibid., §§137 – 144.
[17] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 15 dicembre 2016, §159. Principio già riconosciuto a partire da Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, ricorso n. 5310/71, sentenza, §62 ma anche in altre celebri sentenze come Corte EDU, Jalloh c. Germania, ricorso n. 54810/00, sentenza 11 luglio 2007, §67
[18] Come non citare la celebre sentenza Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, ricorsi nn. 43517/09 e altri sei, sentenza 8 gennaio 2013.
[19] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 15 dicembre 2016, §§202 – 212.
[20] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 1° settembre 2015, §156.
[21] Corte EDU, Khlaifia e altri c. Italia, cit., sentenza 15 dicembre 2016, §246.
[22] Ibid., §§246 – 255.
[23] Come affermato anche in Corte EDU, De Souza Ribeiro c. Francia, ricorso n. 22689/07, sentenza 13 dicembre 2012, §82.

30 anni, attualmente attivo nel ramo assicurativo, abilitato all’esercizio della professione forense, laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con tesi sulla responsabilità medico-sanitaria nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e vincitore del Premio Sperduti 2017.
Vice-responsabile della sezione di diritto internazionale di Ius in itinere, con particolare interesse per diritto internazionale, diritti umani e diritto dell’Unione Europea.
Già autore per M.S.O.I. ThePost e per il periodico giuridico Nomodos – Il Cantore delle Leggi, ha collaborato alla stesura di una raccolta di sentenze ed opinioni del Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo Paulo Pinto de Albuquerque (“I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni dissenzienti e concorrenti 2016 – 2020”).